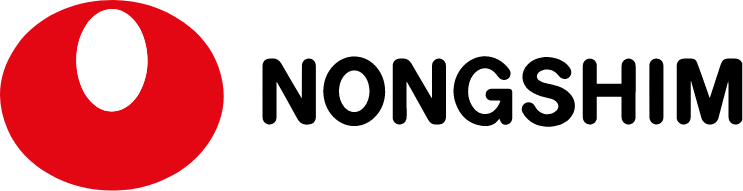In “M” Lee Myung-se porta a compimento il percorso dei film precedenti, imprimendo a ciascuno dei temi che gli sono cari una torsione iperbolica: l’inseguimento amoroso si sposta dallo spazio fisico a quello mentale, la sperimentazione sul linguaggio cinematografico e la frammentazione del montaggio si sciolgono in una completa perdita dei punti fermi, lo sguardo al cinema occidentale diventa omaggio. “M” incontra il Kubrick di “Shining” e il David Lynch di “Lost Highway” e “Mulholland Drive”. Seduto di fronte al suo portatile Min-woo digita compulsivamente la scritta “less poetic more specific”, come il Jack Torrance kubrickiano. “poetic” e “specific” sono proprio Mimi e Eun-hye: la prima è il ricordo di un’innocenza perduta, di una purezza creativa e adolescenziale che Min-woo rivede nel “film” del suo ricordo (in una scena si immagina mentre “vede” se stesso e la giovane Mimi attraverso un vetro), e di cui sente la nostalgia (alcune situazioni fanno pensare al Lee Chang.dong di “Peppermint Candy”), mentre Eun-hye è il compimento dei sogni di successo e di fortuna. Ma Mimi è un fantasma buono, un genius loci dell’anima, che gli insegna a far uscire le parole della storia che vuole scrivere come il fumo di una sigaretta. Min-woo la incontra al bancone di un bar (il Lupin: ammiccamento francofono a tutto ciò che fugge e non viene catturato), che non è più reale di quello di “Shining”, in cui tutti gli avventori (e Min-woo per primo) non sono altro che fantasmi. Ma il Lupin assomiglia anche al club Silencio di “Mulholland Drive”, dove nulla è come sembra e i sogni diventano incubi e realtà. Lee Myung-se ha imparato bene la lezione lynchana: completa sovrapposizione dei piani del reale e dello straordinario (in nessun momento possiamo decidere che quello che vediamo è realtà, o sogno, o ricordo, o allucinazione, o semplicemente desiderio), montaggio de-strutturante (i piani e le situazioni si susseguono senza linearità), ma soprattutto un uso dello spazio della scena come generatore di illusione. Il lavoro sulle aree buie dell’inquadratura che, da “Nowhere to hide”, è una delle marche stilistiche del regista, qui diventa registro principale dell’immagine: dal buio, dal nero, dal profondo dell’inquadratura i personaggi escono, entrano e passano da un mondo all’altro. “M” è il film più ambizioso di Lee Myung-se, e per certi versi quello più “estremo”; non a caso, dopo la presentazione al Pusan International Film Festival, ha ottenuto un’accoglienza tiepida dal pubblico coreano. È baciato da alcune straordinarie preziosità visive (il gioco escheriano con le scale mobili, la fotografia di Hong Kyung-pyo, la solita magistrale attenzione per il montaggio e l’inquadratura), e insieme corre il rischio di perdersi nelle sue stese volute di fumo. Ma è una scommessa, ambiziosa, per il nuovo cinema coreano.