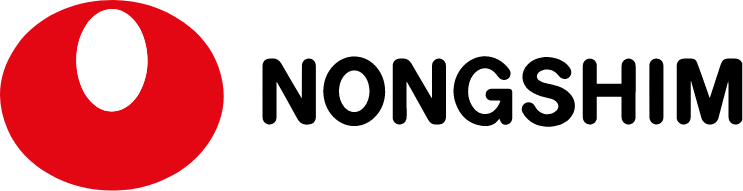Archivio ospiti / BONG JOON-HO

BONG JOON-HO

Nome in coreano:
봉준호
Pronuncia del nome:
Bong Joon-ho
Professione:
Regista
Data di nascita:
14 settembre 1969
Genere:
Uomo
Biografia
Bong Joon-ho nasce il 14 settembre 1969 a Daegu, in Corea del Sud, ultimo di quattro figli. Suo padre è professore di grafica presso l’Università locale, mentre la madre (figlia di Park Tae-won, celebre scrittore sudcoreano, con simpatie socialiste) è insegnante alla scuola elementare. Intorno ai sette anni, Boon Joon-ho e sua famiglia si trasferiscono a Seul, in un appartamento vicino al fiume Han, che avrà un ruolo importante nel film The Host. Essendo uno studente eccellente, nel 1988 Boon Joon-ho riesce ad accedere facilmente alla prestigiosa Yonsei Università. Durante gli anni universitari fonda insieme a due amici un cineclub, chiamato «The Yellow Door» ed è proprio questa esperienza a spingere Bong Joon-ho alla realizzazione del suo primo cortometraggio: White Man (1993). Il film viene presentato al pubblico dall’Association of Korean Independent Film and Video e riceve numerosi premi in festival regionali. Dopo essersi laureato in sociologia nel 1994, frequenta la Korean Academy of Film Arts (KAFA) dove realizza il cortometraggio Memories in my Frame (1994), anche se è soprattutto il suo saggio finale Incoherence (1994) a renderlo famoso presso il pubblico e a farlo apprezzare dai critici. Bong Joon-ho dovrà aspettare ancora qualche anno prima di poter realizzare il suo primo lungometraggio, Barking Dogs Never Bite (2000), che viene ignorato non solo dal pubblico, ma anche dalla critica. Nel 2003 realizza il suo secondo film, Memories of Murder, tratto da una caso di cronaca nera realmente accaduto e mai risolto e perciò capace di destare molte aspettative presso il pubblico. Il film non delude, attirando ben sei milioni di spettatori e raggiungendo uno degli maggiori incassi di quell’anno in Korea. Grazie a Memories of Murder la critica inizia a interessarsi al suo cinema e Bong Joon-ho diventa ben presto apprezzato anche all’estero, dove viene invitato a numerosi festival. Prima di girare il suo terzo lungometraggio, The Host (2006), realizza due corti: Influenza (2004), prodotto dal Jeonju International Film Festival, episodio di Digital Short Films by Three Filmmakers e Sink & Rise (2004), prodotto per il 20th Anniversary Project of KAFA, episodio di Twentidentity. Lo spettacolare The Host, con tredici milioni di spettatori, è uno dei maggiori incassi degli ultimi anni. Nel 2008 Bong Joon-ho gira Shaking Tokyo, uno dei tre episodi che compongono il film giapponese Tokyo!. Nel 2009 realizza Mother che è presentato al Festival di Cannes (nella sezione «Un Certain Regard») e che conferma Bong Joon-ho come uno dei più interessanti e coraggiosi registi del cinema asiatico contemporaneo. Nel 2013 realizza il film di fantascienza Snowpiercer, tratto dalla graphic novel Le Transperceneige: prima produzione internazionale in lingua inglese e con un cast di fama mondiale.
Il 2017 è l'anno del fanta-ecologico Okja, prima pellicola del regista distribuita direttamente sulla piattaforma Netflix.
Parasite (2019), l'ultimo film di Bong Joon-ho, ha consolidato il suo successo internazionale, rendendolo vincitore della Palma d'Oro e di quattro premi Oscar, di cui il miglior film.
Presentazione Critica
Il cinema di Bong Joon-ho svela forse più di ogni altro i caratteri peculiari di quella straordinaria rifioritura che il cinema coreano ha attraversato nel primo decennio del nuovo secolo. Il binomio tra incassi e qualità (che raramente si verifica oggi sia nel cinema americano che in quello europeo), che ha contraddistinto questa stagione ha fatto sì che autori come Bong emergessero con non troppe difficoltà, imponendosi in egual misura sia all’attenzione della critica internazionale che del pubblico. Scorrendo i titoli che compongono la filmografia del regista coreano si scopre che accanto a film difficili e poco concilianti come Barking Dogs Never Bite (2000) o Mother (2009), pellicole dai temi a prima vista poco commerciali, figurano titoli come Memories of Murder (2003) o The Host (2006), che risultano tra i maggiori incassi coreani degli ultimi anni. La cosa non dovrebbe sorprendere visto che Bong fa parte a pieno titolo di quel gruppo di cineasti che, pur percorrendo strade diverse, fanno parte dello stesso orizzonte creativo. Non si spiegherebbe altrimenti, ad esempio, come i drammi intimisti di Kim Ki-duk, Hur Jin-ho e Lee Chan-dong siano popolari quanto gli spettacolari blockbusters di Park Chan-wook e Kwan Kyung-taek. La ricchezza di questo cinema sta proprio nella sua capacità di mescolare in una forma molto libera e originale temi e linguaggi diversi tra loro. Sul piano poetico le storie d’amore finiscono male, le amicizie si interrompono, i poliziotti perdono fiducia in quello che fanno, le riconciliazioni e le rivalse sui soprusi sono spesso effimere, si aprono complesse riflessioni sulla storia e la società del Paese. Sul piano stilistico non c’è un genere che si impone sugli altri, così il melodramma (la cui tradizione cinematografica in Corea è fortissima) prospera accanto alla commedia, al thriller, all’azione, all’horror, all’animazione e tutti sono attraversati da una spinta interna che tende a ridiscutere i meccanismi che sono alla base dei generi stessi: il montaggio di questi film non è quello frenetico di Hong-Kong, il ritmo è spesso dilatato e le soluzioni espressive imprevedibili, sintomo che i cineasti coreani guardano con interesse alla tradizione del cinema moderno europeo (Neorealismo e Nouvelle vague in particolare) e giapponese. Il cinema di Bong è perfettamente inserito in questo quadro e ne rappresenta una delle più vistose articolazioni, grazie anche alla particolare irrequietezza creativa del regista stesso. Nei suoi film, che sono proprio un’originale sintesi tra sguardo d’autore ed esigenze commerciali, si ritrovano molte delle caratteristiche poetiche e stilistiche del cinema coreano dell’ultimo decennio. I primi lavori di Bong, realizzati all’inizio degli anni Novanta durante e dopo gli anni universitari, grazie alle sue molteplici esperienze, prima come socio fondatore del cineclub «The Yellow Door», poi come studente della prestigiosa Korean Academy of Film Arts, non hanno valore di pura testimonianza, ma presentano già (anche se in nuce) i principali tratti caratteristici di quelli che poi saranno lo stile e la poetica del futuro cineasta. Il primo cortometraggio The White Man (1993), ad esempio, seppur immaturo e disomogeneo, presenta una situazione ben chiara: un uomo della classe media trova un giorno per caso un dito mozzato (il riferimento immediato è a Blue Velvet, 1986, di David Lynch), che utilizzerà nella sua giornata nei modi più svariati. Siamo cioè di fronte a una chiara emersione di Unheimlichkeit, ovvero della trasformazione del familiare (la ripetitiva vita quotidiana di un lavoratore) in qualcosa di perturbante (l’eccezionalità di trovare qualcosa di misterioso e inaspettato e soprattutto di portarlo con sé); il cortometraggio non va oltre, non suggerisce ulteriori sviluppi della storia, tuttavia questo tratto poetico sarà alla base dei successivi lungometraggi Barking Dogs Never Bite, Memories of Murder e The Host. Un altro motivo ricorrente nel cinema di Bong è quello che emerge dal suo terzo cortometraggio, dal titolo quanto mai esplicito, Incoherence (1994): un atteggiamento di condanna morale nei confronti di personaggi appartenenti alle classi dirigenti coreane, che abusano del loro potere a discapito della gente comune. Sia in White Man che in Incoherence le classi meno abbienti del Paese vengono rappresentate come le uniche vere vittime di un sistema ipocrita e corrotto. Alla luce di tali considerazioni si può considerare il primo lungometraggio di Bong, Barking Dogs Never Bite, già come un’opera matura, in cui convergono e vengono strutturati i motivi dei lavori precedenti. Ritenuto giustamente uno degli esordi più interessanti del cinema coreano degli anni Duemila, il film, le cui iniziali ambizioni (affidare la parte del protagonista al famoso attore Lee Sung-jae) vennero mortificate dalla scarsità del budget, è un’intelligente e originale commedia nera (genere piuttosto comune nel cinema coreano contemporaneo). Partendo e non muovendosi mai da un luogo circoscritto (un enorme palazzo di periferia molto simile a quello in cui Bong abitava con la moglie prima di diventare famoso), la vicenda intreccia i destini di un composito gruppo di personaggi (un ricercatore che per avere una cattedra deve corrompere un barone, la moglie nevrotica incinta, una contabile che sogna di diventare un’eroina dei media) la cui esistenza viene sconvolta da un fatto apparentemente comune, la sparizione di un cane. Questo piccolo avvenimento serve a Bong per impostare l’intero film: il fatto assume per ogni personaggio un significato diverso e spinge ognuno di loro a incontrarsi o scontrarsi con gli altri. E’ in questo modo che pur partendo da un ambientazione fortemente realistica, con un tono quasi da documentario sociale, il regista coreano costringe i suoi personaggi a rivelare pian piano la loro natura più intima (paure, ossessioni, manie, ambizioni, ecc.) e a far dunque emergere nuovamente il volto più nascosto e perturbante del quotidiano. Si intravede inoltre in Barking Dogs Never Bite un chiaro atteggiamento nei confronti dei meccanismi di genere: il film è una commedia nera che evita ogni tipo di stereotipo non solo perché gli spettatori osservano dei personaggi assolutamente anonimi alle prese con circostanze straordinarie (si pensi all’effetto comico di persone che si inseguono in pieno giorno per i corridoi esterni di un palazzo), ma anche perché lo stile ama giocare su vari registri, dal comico al thriller, dall’azione all’horror, mentre addirittura nel finale si sfiora la tragedia: è per questo che nel film scorre una persistente nota di amarezza e un pessimismo di fondo. E’ facile intuire che per il regista coreano la solitudine e la sconfitta sono uguali ovunque e per chiunque. Come accade per i suoi colleghi della stessa generazione, Bong ama dunque far emergere una propria e originale lettura della realtà (e del cinema) attraverso il confronto con il sistema di regole che costituisce l’architettura di genere. In tal senso gli esperimenti fatti sia con Memories of Murder che con The Host, ma in parte anche con Mother, sono assai significativi. Prendiamo in considerazione proprio Memories of Murder, realizzato dopo il mezzo fiasco (in termini di pubblico) che ha accompagnato il suo primo lungometraggio: per il secondo film il regista coreano ripesca uno dei più discussi e raccapriccianti casi di cronaca nera della Corea degli anni Ottanta, quello di un serial killer di ragazze che non fu mai arrestato dalla polizia. E’ chiaro che Bong cerca con questa scelta di soddisfare un determinato orizzonte di attesa da parte del pubblico, ovvero quello di ripercorrere sul piano della finzione l’inchiesta che tanto aveva sconvolto e interessato l’opinione pubblica. La scatola in cui confezionare il film sembra essere già pronta ed è quella del thriller: tuttavia, sin dall’inizio, si capisce che al regista coreano il consueto sviluppo narrativo del genere (omicidio, indagini, scoperta del colpevole) non interessa, ma viene semplicemente usato per far emergere una molteplicità di realtà nascoste. Non c’è infatti nulla in Memories of Murder che possa ricordare la mitologia del genere: la tentacolare metropoli viene sostituita da un anonimo, ma surreale paesino di campagna, di detective non ce n’è uno, ma due e diversissimi per temperamento e metodi, ma soprattutto il finale, costruito con un sapiente climax, non porta dove dovrebbe condurre, ovvero alla scoperta dell’identità dell’assassino seriale. Il giallo si chiude infatti con un nulla di fatto: tutti gli sforzi sono stati vani e gli eventi, come la realtà in cui si sono verificati, restano un mistero insolubile. Dietro a questa labile e incerta traccia, ne emerge, forte, un’altra, dal carattere più politico, che porta Bong a riflettere sulla situazione sociale della Corea sotto la dittatura militare di Park Chung-hee, con la povera gente che era periodicamente costretta non solo a rifugiarsi nelle proprie case a causa dei blackout (imposti per preparare la popolazione a un’eventuale conflitto armato), ma diveniva spesso facile preda di violenze e angherie di ogni tipo, perpetrate da una polizia e da un esercito incompetenti, in cerca, come in questo celebre caso, di un colpevole a tutti i costi. La dimensione politica è uno dei tratti più interessanti del cinema di Bong: rileggendo il campione d’incassi The Host da tale punto di vista, esso assume significati più ampi e profondi di quelli che si potrebbero pensare a prima vista. Nonostante i dieci milioni di dollari spesi per gli effetti speciali e la volontà di andare incontro ai gusti del pubblico con un film spettacolare e ad alto tasso di adrenalina, che mette insieme generi diversi come il disaster movie, la science fiction e l’horror, The Host può essere considerato alla stregua di un film d’autore perché contiene in sé tutte le caratteristiche di un’opera di Bong, a partire proprio da un preciso atto d’accusa formulato in termini politici. La mostruosa creatura che emerge dal fiume Han e semina terrore e distruzione sulla terraferma non è altro che il risultato dell’inquinamento delle acque perpetrato nell’assoluta illegalità dalle truppe americane stanziate in Corea. Usando una felice metafora, Bong fa emergere ciò che di mostruoso c’è nella politica del proprio paese, “giustificando” in un certo senso la presenza di questa raccapricciante creatura e facendola diventare il simbolo dei mali incontrollabili della società coreana. Non è un caso che a lottare contro il mostro sia una famiglia di persone semplici: il nonno che cerca di salvare la propria nipotina insieme ai suoi tre sgangherati figli ha una misera bottega alimentare sulle rive del fiume. E’ quindi ancora uno sconosciuto qualunque a dover assurgere al ruolo di eroe, non certo la polizia, né tanto meno l’esercito, che invece, dietro il paravento della sicurezza, si buttano a capofitto in un’operazione di repressione del dissenso e delle libertà individuali. In The Host l’emersione del perturbante nel quotidiano è dunque un’operazione più manifesta, ma non meno sottile rispetto a Barking Dogs Never Bite o a Memories of Murder proprio perché le implicazioni politiche del film danno al connubio realismo/fantasia una veste più ampia che nei film precedenti. L’enorme successo di pubblico del film non dovrebbe stupire ed è in un certo senso la perfetta conferma della consuetudine che vuole il cinema coreano dell’ultimo decennio come un perfetto mix tra intrattenimento e riflessione critica.
Anche se, soprattutto dopo The Host, Bong si è imposto come uno dei maggiori e fortunati registi coreani di oggi, non ha mai perso il gusto della sperimentazione e nemmeno il desiderio di confrontarsi con le short stories, in cui poter proseguire le sue riflessioni poetiche e le sue provocazioni stilistiche. Ci sono due cortometraggi (ambedue inseriti in altrettanti film a episodi), Influenza (2004, contenuto in Digital Short Film by Three Filmmakers) e Shaking Tokyo (2008, parte di Tokyo!) in cui Bong spinge fino all’estremo questa ricerca sugli elementi più nascosti e oscuri della quotidianità: il primo è uno straordinaria rappresentazione della contagiosità del male, mentre il secondo è un incitamento a superare la cronica solitudine di cui sembra essere affetto l’uomo contemporaneo, soprattutto nel Giappone post-industriale. In Influenza il rapporto dialettico tra realtà della violenza e sua rappresentazione viene capovolto a favore di quest’ultima: il progressivo abbrutimento di un uomo che perde il lavoro e si trova in condizioni via via più miserevoli, fino a diventare un efferato criminale, spalleggiato da una complice più crudele di lui, viene raccontato attraverso una serie di quadri fissi, realizzati come se la macchina da presa (digitale) si trovasse al posto di alcune di quelle telecamere di sorveglianza che sono ormai diffusissime nelle metropoli del mondo più sviluppato. La violenza non si concretizza per Bong solo nell’azione, ma anche nell’invasività della visione, che permette a un’entità impersonale (il Potere in senso lato) di controllare la vita di ognuno. E’ significativo infatti come in Influenza le forze dell’ordine arrivino a intervenire (in maniera anche piuttosto goffa) solo dopo che i due criminali hanno compiuto una numerosa serie di furti e angherie: la violenza, suggerisce il regista coreano, interessa alla collettività solo come effetto, ma a nessuno sembrano stare a cuore le cause, prima fra tutte la perdita del posto di lavoro e il progressivo impoverimento della classe media. In Shaking Tokyo la metafora dell’uomo solitario che incontra l’amore per puro caso (in quel momento si verifica una scossa di terremoto che lo costringe a riscoprire la sua umanità perduta) serve in realtà a Bong per dipingere un penetrante e durissimo affresco sull’incapacità di vivere i rapporti umani. Il regista è abilissimo nel partire come di consueto da un semplice fatto quotidiano e a giocare sul piano della dissimulazione: se il protagonista all’inizio vive in un autoisolamento che lo fa apparire agli occhi dello spettatore come un personaggio estremo, si scoprirà ben presto che in realtà la sua condizione non è affatto eccezionale, ma invece è comune alla quasi totalità dei suoi concittadini. Il ribaltamento della situazione iniziale è pressoché totale e così le scosse di terremoto, che servono da raccordo tra una sequenza e l’altra, sembrano rappresentare nuovamente quella primigenia e oscura forza che emerge dal mistero della realtà quotidiana. Per molti aspetti speculare a Memories of Murder è invece Mother, un altro film che ha come struttura quella del giallo, ma che in realtà nasconde ben altre finalità. Anche in questo film Bong descrive la penosa vicenda di due emarginati: una madre che vive di un lavoro poco redditizio e il figlio ritardato, che la società condanna preventivamente come colpevole di un omicidio dalle dinamiche assai oscure. Se il nucleo drammatico del genere in Mother viene rispettato in pieno, con il procedere del film diventa sempre più chiaro che il giallo si trasforma in dramma a partire dal momento in cui la madre si convince che il figlio non è altro che un capro espiatorio e prova a dimostrare la sua innocenza. Il tono del film cambia: di fronte al menefreghismo della polizia, che considera il caso chiuso, la donna procede con le sue personali indagini, che la porteranno tuttavia a scoprire una dolorosissima realtà: è stato davvero il figlio a commettere l’omicidio e lo ha fatto con una straordinaria lucidità. L’elemento tragico del film non sta dunque tanto nel fatto che il figlio verrà scagionato (la polizia arresterà un altro ragazzo disabile), ma nella scoperta da parte della madre di essere stata lei stessa, con il suo atteggiamento estremamente protettivo, a spingere il proprio figlio a commettere il delitto. Sarebbe riduttivo considerare lo stile di Bong solo come una (pur importante) rilettura dei meccanismi di genere, perché il regista coreano persegue con ostinazione una sua idea del linguaggio cinematografico, tesa a evidenziare in ogni inquadratura e nel montaggio un’idea di conflitto e di dialettica visiva tra i vari elementi dell’immagine, coerentemente con l’esigenza di far apparire le cose della realtà quotidiana nel loro aspetto più misterioso e nascosto. Bong ha perfezionato negli anni la sua padronanza della macchina da presa: evitando tanto le acrobazie postmoderne alla Park Chan-wook quanto il pittoricismo estetizzante alla Kim Ki-duk, ha elaborato uno stile «mediano» rispetto a queste due opposte tendenze del cinema coreano contemporaneo. Questo linguaggio si traduce in una serie di opposti, di cui le sue immagini sembrano pervase: aperto/chiuso (come avviene in Barking Dogs Never Bite e in gran parte dei cortometraggi, da White Man a Incoherence, da Influenza a Shaking Tokyo), basso/alto (come in The Host), luce/buio (come avviene nei due thriller, Memories of Murder e Mother), per sottolineare quanto la rappresentazione della realtà sia irriducibile a un unico universo di senso, ma vada in qualche modo continuamente ridiscussa e rinegoziata. In tal senso i molti procedimenti retorici che distinguono lo stile di Bong, dall’ampio uso della profondità di campo e del piano-sequenza all’insistenza sul primo piano ravvicinato, dalla scelta di punti di vista continuamente variabili a un’idea di montaggio interno all’inquadratura, fanno parte di un’idea di linguaggio al contempo antica e moderna, sintomo che Bong ha saputo sfruttare la sua cultura cinefila senza trasformarla in un’inesauribile fonte di citazioni, ma gestendola come punto di partenza per trovare una propria strada espressiva e professionale. Se il cinema coreano oggi può vantare una ricchezza espressiva forse senza eguali nel resto del cinema mondiale, lo deve proprio a questo atteggiamento di continua sfida che i suoi maggiori cineasti conservano nei confronti dell’industria: accettare le regole del business non significa necessariamente omologare il linguaggio in un panorama indistinto, riconoscibile quanto prevedibile, ma cercare un punto di convergenza tra conservazione e ricerca, tra tradizione e innovazione, tra regole e trasgressioni. Il cinema di Bong Joon-ho sta lì a dimostrare come questa strada sia non solo auspicabile, ma addirittura necessaria.
di Marco Luceri