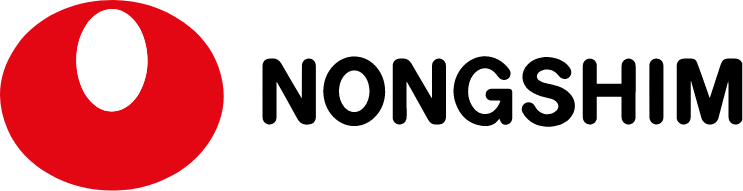Critique
Non poteva esserci occasione migliore di quella offerta quest’anno dal Florence Korea Film Festival per riflettere sulla parabola artistica di Park Chan-wook, uno dei registi coreani più celebri del mondo. Insieme a Kim Ki-duk egli ha contribuito più di ogni altro a quella “New Wave” che, a cavallo tra la fine degli anni Novanta e i primi anni Duemila, ha trasformato una cinematografia asfittica e senza apparente futuro come quella coreana in uno dei movimenti artistici di maggiore spessore a livello mondiale,
I più conoscono Park per la sua “Trilogia della vendetta”, ma se il suo cinema - volutamente eccessivo, traboccante di violenza e di stile, giocosamente a cavallo tra i generi - ha incantato e scandalizzato, divertito e terrorizzato, commosso e inorridito il pubblico e allo stesso tempo colpito la critica ai festival, è perché l’autore coreano ha proposto ogni volta delle traiettorie inedite ed inaspettate. Un cinema in cui la vendetta è in realtà il viatico attraverso cui esperire un più ampio senso del tragico, che colpisce prima la famiglia, il nucleo primario e più forte degli affetti, per poi allargarsi alla società intera e alla realtà del mondo contemporaneo.
La folgorazione di Park per il cinema ha avuto luogo nel segno di Alfred Hitchcock e del suo capolavoro insuperato che è “La donna che visse due volte”, in cui erotismo, necrofilia e violenza diventano uno straordinario, tesissimo e per certi versi ironico poema per immagini. Vedere il cinema di Park sotto la luce di questa giovanile infatuazione può aiutare a riannodare i film di una parabola autoriale comunque ben riconoscibile, che inizia con le difficoltà di sempre e che nei primi esperimenti (il debutto di Park alla regia risale 1992 con “The Moon is... the Sun’s Dream”, un gangster movie su una relazione impossibile, destinata a condannare i suoi protagonisti; mentre il successivo “Threesome”, del 1997, è la storia tragicomica di una rapina di due disperati che si trasforma nella ricerca di un bambino) ha un riscontro così scarso che Park deve ripiegare su una magra carriera di critico cinematografico pur di non rinunciare alla sua passione, quella della regia.
Vocazione che prende corpo al momento opportuno quando lo sguardo del regista prende di petto le lacerazioni che attraversano la società coreana. Lo fa prima nel prezioso cortometraggio “Judgement”, che mette in luce l’ingordigia senza freni dei neo-capitalisti di Seoul, poi con il suo primo, grande capolavoro, che è “JSA – Join Security Area” (2002), adattamento del romanzo di Park Sang-yun “DMZ”. Nasce così uno dei gialli politici più importanti di quegli anni, che dietro i meccanismi di genere (l’indagine che segue la morte di due soldati nordcoreani, avvenuta in un villaggio al confine tra i due paesi) nasconde la necessità di prendere di petto la divisione lacerazione storico-politica più importante di sempre, quella che corre lungo il 38° parellelo (che impariamo a conoscere già dalle primissime immagini, con il ponte “tagliato”, ai lati del quale lavorano le due guardie protagoniste). Lo sguardo lucido di Park mette sotto esame la stringente camicia di forza ideologica che blocca le due Coree, ma si dimostra più indulgente con quelli del Nord che con i suoi compatrioti del Sud (che coraggio!): ognuno ha le sue ragioni, ma quel che conta è scoprire la verità. E in questo il regista dimostra di aver ormai raggiunto un ottimo livello di padronanza del racconto (il lento emergere del passato del maggiore, il finale tanto lirico quanto polemico) e della messinscena (i personaggi chiusi in spazi angusti e illuminati da una luce spettrale), che gli consentirà di raggiungere il suo primo grande successo internazionale.
Ora finalmente Park può avere gli strumenti e le possibilità per mettere in pratica la sua idea di cinema, tanto sul piano visivo che su quello narrativo. Su entrambi i fronti Park è uno sperimentatore, capace di adottare soluzioni insolite per far compiere agli spettatori un viaggio allucinato dentro un mondo violento, che ha smarrito i limiti di ciò che è lecito e ha reso indistinto il confine tra bene e male. E’ l’inizio della trilogia, che ha in “Mr. Vendetta” (definito dallo stesso regista un omaggio a “La vendetta è mia”, film di Shohei Imamura del 1979) il suo primo tassello, con due storie tragiche che si intrecciano in un groviglio di morte senza alla fine lasciare né vincitori, né vinti, ma solo uno sconvolgente ritratto di un mondo totalmente ripiegato su se stesso. Il crudo realismo, ancora acerbo in alcuni passaggi, resta vivido per la sua forte spontaneità, per il suo essere “sporco” e per nulla conciliante, proprio come la maschera espressiva che iniziano ad assumere gli attori che dirige, chiamati a mettere al servizio le loro facce da uomini e donne comuni all’emotività più pericolosa ed efferata. Un’escalation di violenza che trova la sua sublimazione nel secondo capitolo della trilogia, quello più riuscito, “Old Boy”, che al Festival di Cannes non ce la fa ad agguantare la Palma d’Oro (il presidente della giuria, Quentin Tarantino, non riesce ad assegnargliela), ma nel compenso proietta Park tra i nuovi maestri-cult. E se nella memoria di ogni spettatore appassionato di cinema coreano indelebile resta la sequenza del corridoio e del martello, o quella in cui un polipo viene sbranato vivo, o ancora quelle in cui si susseguono torture e mutilazioni, “Old Boy” è a tutti gli effetti il film della maturità, quello in cui la sua visione del mondo si struttura in una precisa architettura narrativa (la vendetta non è una sola, ma un groviglio di strade che si incrociano, sovrapponendosi). Una poetica dell’eccesso che tuttavia non resta tale perché si trasforma in strumento di denuncia, contro la violenza inspiegabile e immotivata che la società ci costringe a fare e a subire.
Mentre lavora al completamento della trilogia, Park realizza alcuni piccoli, ma non meno importanti progetti, l’episodio “NEPAL (Never Ending Peace and Love)” del film collettivo sui diritti umani “If You Were Me” e successivamente prende parte al corale “Three... Extremes” in collaborazione con Chan Fruit e Takashi Miike, realizzando l’episodio “Cut”, incentrato sull’odio per la posizione sociale e sulla paranoia che questo può generare e che rientra ampiamente nella saga della vendetta: «Vivere senza odiare è quasi impossibile, non c’è niente di male nel fantasticare circa la vendetta, tutti abbiamo questi sentimenti, l’importante è non agire: nei miei film si parla di paura e dolore, la paura prima dell’azione violenta, il dolore dopo e questo si applica sia alla vittima che al carnefice» - dirà a margine di quel film, preparandosi a chiarire la traiettoria del terzo e ultimo capitolo, “Lady Vendetta”, che approda alla Mostra di Venezia e che viene salutato con un po’ di freddezza e con le prime accuse di manierismo. In realtà – come spesso avviene in questi casi – si tratta di uno stile che sta compiendo il proprio percorso di maturazione, con una buona dose di novità, non fosse altro perché la vendetta prende il volto tutto al femminile di Geum-ja (la donna viene accusata del rapimento e dell’omicidio di un bambino, ma quello che nessuno sa è che lei ha accettato di andare in prigione al posto del vero assassino, per salvare la sua stessa figlioletta). La svolta verso una sempre maggiore estetizzazione delle immagini e una più forte spinta verso gli effetti choc del racconto (la scena finale è così agghiacciante da richiedere un fuoricampo) ci parlano di un autore inquieto che sente la necessità di iniziare a battere altre strade.
La nuova fase si apre nel 2007 con un film tanto imprevisto quanto struggente, “I’m a Cyborg But That’s OK”, una romantica storia d’amore tra due pazienti di un ospedale psichiatrico, dal tono lirico e surreale, che molto deve al cinema di Tim Burton e alla tradizione del melò intimista. E’ un’opera in cui la follia smette di essere qualcosa di patologico e sanguinario, per farsi astrazione poetica, che Park osserva nel suo farsi quotidiano, senza rinunciare a una buona dose d’ironia e a uno stile visivo che tenta di assecondare questo percorso di ispirata raffinatezza. La critica applaude alla svolta, ma il pubblico volta le spalle al suo beniamino e il film segna il primo flop commerciale per un autore abituato da molti anni a mietere successi. E’ così che il regista coreano capisce di essersi spinto forse troppo in là e cerca di tranquillizzare i suoi appassionati con un film apparentemente più nelle sue corde, come “Thirst”, che gli vale il Premio della Giuria a Cannes e lo riconcilia con il proprio pubblico. E’ una storia di vampiri e della passione sessuale che li lega, e racconta l’orrore dell’esistenza terrena in chiave di horror; ma è anche una riflessione sul senso di colpa e sul libero arbitrio, che come ha detto lo stesso Park, affonda le sue radici nell’educazione cattolica ricevuta da ragazzo (un altro riferimento al cinema del tanto amato Hitchcock). Ma se è vero che dietro ogni grande horror si nasconde un melodramma, ecco allora che Park torna a far scorrere il sangue, ma in una nuova accezione rispetto alla trilogia, e cioè in maniera più grottesca, dissacrante (ricordate il “Dracula” di Coppola?) e infine più cinefila. Ne sono testimonianza molte sequenze, quella del montaggio sulla musica di Bach o il valzer di Jo Young-wook “danzato” dai due protagonisti saltando da un tetto all’altro, quella girata nella casa svuotata, ammantata in un bianco accecante, bella metafora per una love-story autodistruttiva, fino al finale, preda di un romanticismo nichilista portato all’eccesso.
Dopo la “rigenerazione” di “Thirst”, Park si diverte a realizzare un film con un iPhone, l’horror “Night Fishing”, realizzato insieme al fratello Park Chan-kyong, che gli varrà l’Orso per il Miglior cortometraggio alla Berlinale del 2011, e due anni dopo è pronto per girare il suo primo film americano, con Mia Wasikowska e Nicole Kidman nei panni delle protagoniste. Park va così ad ingrossare le fila degli autori asiatici che hanno ceduto alle lusinghe hollywoodiane (vedasi i casi di Chen Kaige, Tsui Hark, Wong Kar-wai, Kirk Wong, John Woo, che ci ha provato più assiduamente, fino a Kim Jee-woon, Bong Joon-ho e Takashi Miike), con esiti spesso discutibili, non fosse altro perché scoprono ben presto di avere a che fare con meccanismi produttivi notevolmente diversi da quelli a cui sono abituati e senza quella piena libertà creativa che si aspetterebbero. Lo script di “Stoker”, scritto da Wentworth Miller, appare comunque perfetto per Park, trattandosi della storia di una famiglia lacerata da un odio che cresce sottopelle, per poi deflagrare in una violenza ineluttabile. Resta delusi chi si aspetta una nuova “vendetta” magari in salsa americana perché il regista coreano sovverte canoni e aspettative, giocando con lo spettatore, ingannandolo e depistandolo per poi spiazzarlo con un finale beffardo e immorale che ribalta il senso di quanto aveva anticipato all’inizio della sua storia, per un film volutamente astratto e colto, languido e impregnato di un sangue tanto invisibile quanto metaforico, ma non per questo meno efficace. E’ un Park ispiratissimo quello di “Stoker”, un Park sempre più hitchcockiano, che per il suo ritorno a Cannes, nel 2016, con “The Handmaiden”, prosegue sulla strada torbida del film precedente, presentandoci una nuova storia (la vicenda è ambientata nei primi anni Trenta, nella Corea occupata dai giapponesi) fatta di doppi, ambiguità, dettagli, sguardi che spiano, s’incrociano, si nascondono, s’incontrano e accavallano. Ancora una volta lo sconvolgimento dell’equilibrio passerà dalla violenza all’interno di una famiglia piena di inconfessabili segreti. Ma a fare da collante è una sconvolgente carica erotica, che si trasforma in meccanismo narrativo e in seduzione visiva e concettuale. Liberamente ispirato al romanzo “Ladra” di Sarah Waters, il film mette in scena una situazione e due sorprendenti ribaltamenti di campo, in cui esplodono le passioni umane più trascinanti, quelle legate al desidero, alla bramosia, all’amore e al sesso. Che sia il sogno di realizzare una propria, personale versione de “La donna che visse due volte”? Se fosse così, il cerchio si chiuderebbe.